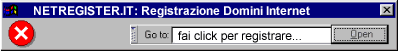
INTRODUZIONE
Intorno al '20 Rivoltella godeva di una propria autonomia amministrativa anche se le sue vicende spesso si incrociavano con quelle di Desenzano : entrambe si trovavano sull' antico percorso della via Gallica, erano state interessate dal passaggio alternato delle truppe austriache, francesi, mazziniane e, dal 1850, erano attraversate dalla linea ferroviaria Brescia-Verona ampliata poi nel 1854 da Milano a Venezia.
Forse proprio per questa vicinanza svilupparono nel tempo caratteristiche così diverse : indole commerciale per Desenzano, agricola per Rivoltella.
Anche gli stemmi della città sottolineavano questa differente vocazione economica : il lago e le torri, che si dice sorgessero a lato del porto, per la prima, simboli del porto, dei commerci e del traffico lacustre ; un albero, un cervo, un cinghiale, simboli della Selva Lugana, per la seconda, orientata quindi verso l'entroterra.
Proprio in una famiglia di contadini rivoltellesi io sono nato nel 1924, in una cascina situata ai margini del centro abitato.
Soltanto tre anni dopo, quando nacque mia sorella, Rivoltella non era più un Comune, ma una frazione di Desenzano. Già c'era stato un tentativo di unificazione dei due comuni nel 1797, durante la Repubblica Cisalpina; ma col ritorno degli austriaci il paese riuscì a riconquistare la sua indipendenza amministrativa. Durante il fascismo, in conseguenza della politica di riorganizzazione delle provincie italiane, i comuni più piccoli vennero soppressi. Era il 26 luglio 1926 quando con decreto regio n. 1460 venne sancita la fine del comune autonomo. A nulla valsero le proteste e le dimostrazioni contro il decreto, i capi fascisti intervennero a richiamare all'obbedienza la popolazione, affermando che "il popolo doveva essere silenzioso e disciplinato e accettare quanto è stabilito dalle supreme gerarchie per il bene comune".
RIVOLTELLA NEL XIX SECOLO
Ho trascorso l'infanzia in famiglia con i genitori, i nonni, i fratelli. La vita allora era semplice: gli adulti lavoravano nei campi, le donne accudivano alla casa, all'orto, agli animali da cortile; noi bambini giocavamo all'aria aperta. Tutta la famiglia si radunava per il pranzo e la cena; erano pasti modesti a base di minestre di patate e verze, polenta e lardo, latte; la carne si mangiava raramente e solo nelle grandi occasioni. Alla fine della faticosa giornata ci si ritrovava a far "filò" in estate sull'aia, in inverno nella stalla. È qui che ho sentito le più belle storie della mia infanzia. Ciascuno rievocava con orgoglio gli avvenimenti più importanti della propria generazione
I nonni raccontavano come era Rivoltella nell'800 e noi bambini restavamo ore e ore a bocca aperta ad ascoltare queste storie d'altri tempi.
Senza nascondere una punta d'orgoglio, ci dicevano che gli abitanti di Rivoltella erano molto stimati da quelli dei paesi vicini, che spesso ricorrevano al loro aiuto in caso di bisogno. Già allora nel paese spiccavano personaggi degni di nota per l'impegno nello svolgere il loro lavoro o per le loro invenzioni: al signor Francoli appartenevano la già famosa falegnameria e la distilleria della grappa; il signor Anselmi aveva la bottega artigiana per la riparazione delle carrozze e per la lavorazione del ferro. Il nonno mi diceva che era conosciuta già al tempo della Repubblica di Venezia nel 1400 perché si trovava su un'importante via di comunicazione tra Brescia e Verona.
Ai suoi tempi chi voleva dei ferri battuti a regola d'arte si rivolgeva proprio agli Anselmi. Nello stesso cortile si trovavano le cantine dei Clomer. Sempre in paese c'era l'officina meccanica del Memini, inventore del carburatore; anche Masotti veniva ricordato per il suo notevole ingegno: grazie all'invenzione della trebbiatrice meritò un riconoscimento internazionale.E che dire del grande Malagrida? Egli è stato il capomastro nella costruzione della Torre di S. Martino iniziata nel 1865 e inaugurata nel 1893.Questa è stata edificata in marmi di S. Vigilio che arrivavano a Madonna Della Villa dove era stato predisposto un porticciolo per lo scarico delle merci; da lì con dei carri trainati da buoi venivano portati a S.Martino.Malagrida lavorava spesso con il fratello Piero Malagrida , insieme costruirono le prime sale delle terme di Sirmione, e molte case in Rivoltella
Malagrida Luigi morì all' età di 67 anni il 17 gennaio 1904 , era stato sposato per molti anni con Francesca Galeppini morta il 10-04-1916 .
Solo dopo la prima guerra mondiale la popolazione rivoltellese si accorse di non aver manifestato gratitudine ad un cittadino che col proprio lavoro si era guadagnato tanta fama, così si diffuse il desiderio di murare nella storica torre di S.Martino una lapide a ricordo del capomastro e dei suoi collaboratori nella suddetta costruzione.
Era il 3 Maggio 1921 quando partì la richiesta formale inviata dalla società S.MARTINO- SOLFERINO al Consiglio comunale di Rivoltella.
Il 2 Ottobre 1921 il comune diede la notizia della decisione di affiggere questa lapide, nello stesso giorno ci fu la cerimonia di inaugurazione.
Alle ore 9.30 si celebrò la messa nell'ossario, da lì si raggiunse poi la Torre.
Questo è il testo del manifesto affisso su tutti i muri del paese:
RIVOLTELLA SUL GARDA
PER LE ONORANZE AL CAPOMASTRO MALAGRIDA
Concittadini !
Sappiamo che la torre monumentale di S.Martino venne costruita da un rivoltellese: dal capomastro Malagrida Luigi. Il fascino delle memorie che S.Martino serba della storica battaglia e l'importanza e il significato turistico della magnifica opera d'arte attraggono sempre sul suo colle noi e i forestieri. Ebbene sul marmo che ostende al nostro riconoscimento i nomi dei valorosi che la idearono e compirono, il nome di Malagrida Luigi, prima mai ricordato, per l' interessamento del comitato per le sue onoranze e del comune, figurerà Domenica 9 Ottobre nello scoprimento di un' apposita lapide.
Alla patriottica manifestazione che è insieme soddisfazione del nostro orgoglio paesano, siete invitati numerosi, colle Associazioni ed i vessilli.
La riunione sarà all' ossario per la Messa delle ore 9:30, donde poi si salirà alla Torre, sull' atrio della quale è la lapide e ove vi saranno parole di circostanza.
Il Comitato ed il Comune.
RIVOLTELLA SUL GARDA 2 OTT. 1921
Il dottor Anselmi... nessuno in paese poteva dimenticarlo!
Emanuele Anselmi nacque il 20 giugno del 1859, di grande ingegno, nonostante le difficoltà economiche della famiglia, venne avviato agli studi prima nel Seminario Vescovile di Verona, poi nel Liceo di Desenzano, quindi nell'Università Patavina dove si laureò a pieni voti in Medicina e Chirurgia nell'anno 1883. Nel corso della sua vita si sacrificò per gli altri, sia per la loro salute che per la loro felicità.
Vinto il concorso per medico condotto a Bedizzole, vi rimase per 27 anni consecutivi. Lì si adoperò per la riforma dell'Ospedale e del Ricovero di Mendicità, vi fondò l'Asilo d'infanzia e con ogni mezzo si adoperò perché questo avesse un avvenire stabile e duraturo.
Frattanto il Patrio Ateneo di Scienze, Lettere e Arti , lo volle tra i suoi soci ordinari nel 1893, motivando la nomina con gli studi accurati e profondi che egli aveva fatto sulla pellagra , la cui eco si era fatta udire ben oltre i confini della provincia di Brescia.
Dopo quasi sei lustri di permanenza a Bedizzole, l'amore vivo per il paese natale, gli suggerì di concorrere al posto di Medico del Comune di Rivoltella, dove venne accolto con entusiasmo da noi rivoltellesi contenti di avere finalmente tra loro l'uomo di cui tanto andavano fieri.
L'asilo d'infanzia gli dovette la sua nuova vita, fu delegato e animatore della Croce Rossa; portava una parola saggia, ponderata e consolatrice in ogni famiglia, oltre alla competente assistenza nelle malattie.
Dedicò lunghi anni di ricerca agli studi sulla pellagra che mieteva parecchie vittime soprattutto fra i contadini a seguito del consumo di mais guasto e presentò all'Università di Pavia una documentazione accurata su cinque casi verificatisi a Bedizzole.
. Nel 1889 per opera di un paziente studioso di Desenzano, il professor Piatti, venne riscoperta ed isolata la fonte minerale di Sirmione (la fonte di Catullo).
L'Anselmi con altri colleghi intraprese lo studio della fonte ed, in pochi anni, egli ed un altro rimpianto medico condotto, il Lombardi, furono in grado di pubblicare una doppia serie di dati clinici sulla fonte, che formano ancora oggi il capo saldo del programma terapeutico di quella stazione. Il 3 maggio 1914, in occasione del 25° anniversario della riscoperta della fonte Boiola, tenne un magnifico discorso in cui esponeva le sue idee circa il far assurgere la Stazione Termale di Sirmione all'altezza delle consimili di Salsomaggiore e di Montecatini.
Poco dopo scoppiò il secondo conflitto mondiale ed in questo periodo l'opera di Emanuele Anselmi quale Presidente del Comitato di Assistenza Civile in Rivoltella fu sublime: recò aiuto e conforto a chi ne aveva bisogno, sollecitò soccorsi da ogni parte, sempre animato da sincero patriottismo.
Morì nel luglio del 1916 amato e rimpianto da tutti.
.
Dato che Rivoltella era prevalentemente agricola, molto nota era la coltura della vite che, secondo mio nonno, forniva vini generosi e squisiti, capaci di competere con altri delle migliori posizioni del lago; nonostante questa produzione fosse poco conosciuta, era vanto del paese aver mandato, tempi addietro, vino in Svizzera, in Germania, e buona parte era consumata nel bergamasco; uno dei migliori vini era quello del vigneto di San Donnino, citato anche nella poesia " Sileno sul mella ", scritta da Bagatta nel 1807.
Nel 1859 fu istituita a Salò la prima Società Operaia di Mutuo Soccorso bresciana. Sull'esempio salodiano altre società sono nate poco dopo, a Desenzano e Lonato nel 1862 e a Rivoltella solo due anni dopo.
Quanto all'istruzione, già allora si trovavano tre scuole inferiori: una maschile e una femminile nel capoluogo e una mista a San Martino. Per chi voleva proseguire gli studi, a Desenzano vi erano il ginnasio ed una scuola tecnica parificata.
Esisteva a Rivoltella la Congregazione di Carità o Pio Luogo, che aveva beni patrimoniali per il soccorso dei poveri e degli infermi ; amministrava tali beni il signor Novelli che provvedeva anche alle scuole.
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Agli inizi del novecento a Desenzano e Rivoltella "la lira valeva più dell'oro" perché il traffico commerciale con l'Austria e la Germania era piuttosto intenso ed a questo si aggiungeva il turismo di élite, soprattutto dai paesi di lingua tedesca
.
Le strade intorno al lago erano di terra battuta polverosa, spesso con buche e solchi lasciati dai carri.
Il collegamento tra le zone rivierasche avveniva tramite il lago, mediante il servizio dei battelli, che oltre a trasportare passeggeri trasportavano anche le merci.
Nel paese si conoscevano tutti , non c'erano segreti ed ognuno aveva un incarico.Mio padre ricordava bene quel periodo, perché aveva l'età giusta per essere chiamato alle armi.
Dal 28 giugno 1914 con l'assassinio del duca Francesco Ferdinando d'Austria a Sarajevo, cominciarono a soffiare venti di guerra, si discuteva nei bar, nelle piazze e nelle osterie tra interventisti e neutralisti.
La guerra sul fronte francese e russo cominciò ben presto a far sentire le sue pesanti conseguenze economiche: i forestieri non arrivavano più sulle sponde del Garda, e gli scambi commerciali diminuirono notevolmente.
Nei comuni di Desenzano e Rivoltella erano nate idee patriottiche ed una delle persone più attive era il Dottor Anselmi. Le società <> di Rivoltella e <> di San Martino organizzarono una serie di conferenze, tenute dallo stesso Dott. Anselmi, che sosteneva la necessità di creare uno staff d'infermiere che potessero prestare soccorso ai feriti di guerra sul campo di battaglia. Egli diceva: >.
Il 19 maggio i piroscafi cessarono totalmente il servizio, ed il 24 dello stesso mese fu dichiarata guerra all'Austria.
Frattanto il Dott. Anselmi iniziava le lezioni pratiche di medicina per tutte le donne del comitato d'azione pro Croce Rossa. Nel comitato vi erano le donne delle famiglie più in vista di Rivoltella quali, Carmen Clomer, la nobildonna Annetta Cavalli, la Nobildonna Torchiani Irene, la nobildonna Gilda Arci, la contessa Elisa Anselmi e la nobildonna Maria Terzi. Tra i primi soldati a partire c'erano anche Malagrida Giuseppe , figlio del grande capomastro e Masotti Giuseppe, deceduto poi in combattimento.
La maggior parte dei combattenti sui fronti era costituita da modesti lavoratori che lasciavano mogli e figli in condizioni assai vicine alla miseria, di conseguenza, a Rivoltella si fece una riunione a beneficio delle famiglie povere. Nell'asilo infantile si ritrovavano i membri del comitato "i maestri" e parlavano delle guerre di indipendenza e di quella attuale.
I membri del comitato di preparazione civile e di assistenza si impegnavano invece a fornire alimenti e indumenti alle famiglie in miseria.
Desenzano e Rivoltella avevano un ruolo di retrovie ed offrivano conforto ai soldati che passavano per i rifornimenti o che andavano al fronte.
Il 1916 fu l'anno cruciale, infatti di tanto in tanto c'erano bombardamenti da parte degli aerei austriaci che uccidevano persone spesso solo per le schegge.
I soldati, a volte, riunivano i ragazzi in castello a Desenzano o di fronte alla torre civica di Rivoltella per raccontare le loro avventure di guerra; tra questi va ricordato il soldato Perotti.
Della guerra però si cercava di parlarne poco, dato che a Desenzano i soldati convivevano tranquillamente con i civili.
Nel 1916 il Dottor Anselmi ribadì la necessità dell'impegno a favore dei mutilati di guerra.
Rivoltella era utilizzata, grazie al lago, anche come retrovia di aerei idrovolanti.
Nel 1916 – 17, a causa del numero elevato di feriti portati a Rivoltella e Desenzano, il castello di quest'ultimo venne trasformato in ospedale.
All'inaugurazione c'erano quasi tutti gli abitanti dei due paesi.
Dopo qualche mese fu anche utilizzato per i civili.
Il 24 ottobre del 1918 le truppe italiane varcarono il Piave in più parti e fu la fine della guerra.
La popolazione di Rivoltella e Desenzano, già dalle 5 del mattino, aveva esposto il tricolore ed alle 15 i negozi vennero chiusi.
Si concludeva così questa brutta esperienza.
I Rivoltellesi hanno ricordato in seguito tutti i loro concittadini caduti nella guerra con un monumento sul quale sono incisi i nomi di coloro che non sono tornati o che sono morti in seguito a ferite o malattie contratte al fronte.
CADUTI IN GUERRA
Giuseppe Masotti (cap.) Scappini Valentino Zaglio Emilio
Teodosio Arrighi (cap.) Vischioni Giuseppe Tosi Oreste
Carlo Pellegrini (ten.) Lonardi Angelo Zaffaina Augusto
Turrini Camillo Castrini Eugenio Rossi Guerrino
Gaspari Celestino Bertoletti Luigi Rossato Anselmo
Melda Giuseppe Venturelli Ernesto Filippozzi Paolo
Bazzoli Giuseppe Amicabile Pietro Mondi Pietro
Memini Valerio Bocchio Giovanni Ugolini Giovanni
Bellini Vincenzo Marchini Antonio
Sartori Agostino Tosi Angelo
Vittolini Alfonso Ruffoni Vincenzo
Zeni Giuseppe Annovazzi Franco
MORTI DI MALATTIA
Piazza Francesco Bazzoli Guglielmo Gaspari Luigi
Renghini Dante Vandin Giulio Mura Anacleto
Malagrida Luigi Crosato Giovanni Queresimo Andrea
Arrighi Giacomo Spagnoli Marco Rizzi Ottavio
Marcoli Pietro Gelmetti Dario Scappini Luigi
Tonoli Giuseppe Moretto Gasparri Spilleri Giovanni
Donati Giovanni Albieri Luigi Spilleri Antonio
Gobello Agostino Baccinelli Guglielmo Ugolini Giuseppe
Darro Giovanni Beschi Angelo
Ronco Giacomo Brentegani Angelo
Piceni Ermenegildo Cappelli Luigi
Sabrini Faustino Della Valle Giulio
Niccioli Narciso Filippozzi Francesco
DISPERSI
Amabile Vittorio Gallina Angelo Ronca Angelo
Bazzoli Angelo Malagrida Agostino Rossi Giacomo
Beschi Luigi Ottolini Pietro Zani Luigi
FRA LE DUE GUERRE
All' età di 10-11 anni avevo poco tempo libero, infatti, quando non andavo a scuola, dovevo aiutare mio padre nella coltivazione dei campi.
Nella mia famiglia eravamo in cinque figli, due femmine e tre maschi , non era una delle famiglie più numerose, altre in campagna erano di dieci o undici persone. Era difficile sfamare tutte quelle bocche! Perciò spesso i bambini, già intorno ai dieci anni, venivano mandati presso altre famiglie per lavorare, li chiamavano "i famei", in cambio ricevevano vitto e alloggio. Le fanciulle invece andavano a servizio presso famiglie agiate.
Era duro il lavoro dei contadini! Tutto allora era fatto con la forza delle braccia; le stagioni e le condizioni atmosferiche regolavano il ritmo del lavoro nei campi. Un certo aiuto veniva dalle macchine da poco inventate come la trebbiatrice con trasmissione a cinghia. La campagna offriva comunque, anche nei periodi di maggior povertà, cibo a sufficienza: erano prodotti dell' orto, grano che, macinato al mulino dei Mura, dava farina per un anno intero, fino al successivo raccolto; i filari di viti di cui la nostra campagna abbondava, erano sufficienti per il vino dell' intera annata; le donne si dedicavano all' allevamento degli animali da cortile da cui ottenevano uova e carne. Un posto a sé occupava il maiale, allevarlo costava poco perché si nutriva degli scarti della cucina e di crusca impastata con l'acqua, in compenso in autunno offriva insaccati, lardo e strutto in sostituzione di olio e burro che dovevano invece essere acquistati. Tuttavia tutti questi prodotti della campagna non erano ad uso esclusivo della famiglia che per la maggior parte li vendeva a gente del paese; col ricavato poteva così comprare ciò che la campagna non offriva, scarpe, abiti, o altro.
Mietitura, trebbiatura, vendemmia erano giornate di festa e di allegria, soprattutto per noi bambini. Ricordo la vendemmia: l'uva, raccolta lungo i filari, veniva versata nei tini, a noi bambini e alle donne il compito di pigiarla con i piedi; il mosto, filtrato da reticelle a maglia molto fine, veniva messo nelle botti dove iniziava la fermentazione. Ricordo che in una cascina si produceva un vino molto pregiato, il "SAN DONNINO" che era famoso anche in altre regioni.
Le famiglie del centro urbano erano solitamente meno numerose, avevano al massimo due o tre figli. Anche in paese si conduceva una vita semplice e sobria. I bambini frequentavano la scuola fino alla quinta elementare, ma spesso coloro che abitavano in campagna si fermavano alla terza.
La scuola elementare era in via Benedetto Croce, dove è ancora oggi, nell' edificio di nuova costruzione; da tempo ormai era stato abbandonato quello al N. 27 di via Parrocchiale, poichè era malsano e buio, lì vi aveva insegnato per tanti anni anche il parroco Don Vignola.
A fianco il Comune aveva costruito anche l'asilo infantile tenuto dalle Suore.
All'asilo i bambini andavano col loro cestino contenente una pietanza o un panino, mentre le Suore preparavano una minestra calda: mi sembra ancora di sentirne l'odore!
A scuola si andava a piedi con qualsiasi tempo, sovente con gli zoccoli, per non consumare l' unico paio di scarpe buone, ed anche a questi si applicava una suola ricavata da vecchi copertoni di bicicletta per farli durare più a lungo possibile.
La scuola elementare allora durava mattina e pomeriggio, la disciplina era rigida e i maestri molto severi, ma anche molto rispettati, non di rado ricorrevano a punizioni corporali vere e proprie di cui tra l' altro nessuno si lamentava: facevano inginocchiare su sassolini distribuiti sul pavimento o percuotevano le mani con i "stropei", ramoscelli di alberi che qualcuno di noi portava da casa.
L'istruzione impartita era sufficiente per acquisire quanto necessario alla vita pratica: chi poteva e desiderava proseguire gli studi andava a Desenzano dove poteva scegliere fra Scuola media e Avviamento, e proseguire poi nel famoso Ginnasio " Bagatta". Pochi però potevano permetterselo, i più, finita la quinta elementare andavano a lavorare.
Rivoltella è sempre stato un paese industrioso: gli abitanti erano attivi, a volte anche creativi. I mulini Mura e Renghini erano importanti per la vita del paese essendo l'entroterra per lo più agricolo. Il mulino Renghini era proprio sul porto nella casa dei Masotti, mentre quello dei Mura era a destra della chiesa di San Biagio. Entrambi utilizzavano l'acqua del Rio Venga.
I Mura erano di origini sarde: il nonno (capostipite della famiglia ) era arrivato nella zona al seguito dell'esercito piemontese nel corpo dei granatieri ed aveva combattuto la 2? guerra di indipendenza; alla fine della guerra si era sposato con una donna di queste zone e qui è rimasto.
I Mura, che già possedevano un mulino a Desenzano, nel 1910 hanno acquistato il mulino a Rivoltella. Allora l'acqua passava sotto le pale della ruota, imprimendovi il movimento necessario ad azionare le macine. Successivamente il livello dell'acqua venne alzato in modo che la caduta dall'alto riuscisse a dare una forza maggiore. L'era dell'elettricità consentì di elettrificare anche il mulino, che diventò così più moderno.
I contadini portavano al mulino le loro granaglie perché venissero macinate e generalmente pagavano i mugnai solo l'anno successivo.
Molti abitanti ( pensiamo che Rivoltella poteva contare allora circa millecinquecento anime ) lavoravano come operai presso gli artigiani del paese.
La falegnameria dei Francoli era la più grossa azienda artigianale, situata dopo la piazza Umberto I sulla strada che portava a Sirmione, di fronte alle villa pure di proprietà dei Francoli. A fianco aveva ancora la distilleria di grappa. Lungo la via San Martino c'era l'officina degli Anselmi, di cui i Rivoltellesi erano fieri. I Memini avevano un'officina per la riparazione dei motori.
La pesca era praticata non per divertimento, come oggi avviene, ma il pesce di lago allora costituiva una importante ed economica risorsa alimentare.
La bicicletta era un bene prezioso, ogni famiglia ne possedeva una , raramente due, veniva tenuta con cura. La usavano prima di tutto gli adulti per andare a lavorare, raramente i piccoli.
Le malattie erano frequenti, a volte erano vere e proprie epidemie che seminavano disperazione fra la gente, spesso non c'erano i soldi per comprare le medicine, per fortuna il farmacista Cavalli , faceva credito alla povera gente oppure accettava come compenso uova, farina o altri prodotti della terra. Nonostante ciò i sentimenti erano sinceri e vivi nell'animo delle persone, ci si voleva bene , quando possibile, ci si aiutava. Per capirlo basta leggere la lettera inviata il 2 dicembre 1920, da Loda Domenico alla fidanzata Veronesi Angelina.
In quel periodo Angelina era affetta da vaiolo, contratto da un accattone che aveva ospitato a dormire nel fienile. Domenico aveva allora 25 anni e Angelina 22.
La malattia passò fortunatamente dopo circa 40 giorni, ma le conseguenze furono visibili ancora per diversi mesi.
Nonostante ciò i due giovani si sposarono un anno dopo.
Ecco il testo originale della lettera.
Rivoltella 2-12-920
Carissima Angelina,
dal giorno 20 m.s. che ricevetti la tua lettera, cioè scritta da tua cognata, e fino ad oggi furono per me tristi giorni.
Giorni impensabili, non potevo trovar chiete in nessun luogo, sentendo che tutti i giorni aggravarsi sempre più, finalmente sentii pochi giorni fa che eri un po' più sollevata; oggi poi nel ricevere una tua lettera, scritta con le tue mani, fu per me una consolazione mai provata nel tempo della mia vita.
E non ti impressionare di ciò che mi spieghi su le tue ultime parole, e se non avesse a passare, Domenico ti vorrà sempre bene, lo stesso. Se è sincero il tuo amore, nessun difetto, nessuna macchia, potrà spezzare il nostro amore.
Altro non ho che di farti coraggio, e vederti presto in perfetta salute, per passare qualche ora in tua compagnia, che altro non desidero.
Ti saluto caramente unito tua famiglia.
Saluti cari un caldo bacio. Tuo affezionatissimo
Domenico.
SOCIALISTI E FASCISTI
La forza politica del partito socialista era alquanto consistente a Rivoltella come del resto a Desenzano, ne facevano parte gruppi di muratori, artigiani, facchini, mugnai, pescatori, barcaioli e ferrovieri.
La propaganda del partito socialista faceva leva sui 500.000 morti della Prima Guerra Mondiale considerati una tragica conseguenza della politica nazionalista e imperialistica del capitalismo contro il quale lottava il proletariato.
A Rivoltella i socialisti ebbero la maggioranza in consiglio comunale con le elezioni del 10 ottobre
1920, quando fu eletto sindaco un semplice muratore, Pietro Pezzotti con grande indignazione delle famiglie più in vista del paese e del parroco che dal pulpito fulminava tutti coloro che erano iscritti al partito della sinistra seminando zizzania nelle famiglie in cui vi erano mariti o fratelli socialisti.
Le sedute del consiglio comunale divennero allora animatissime : la minoranza, che rappresentava gli interessi delle famiglie abbienti, riteneva paradossale che contadini, muratori, manovali tenessero le redini del paese.
Il movimento fascista organizzato era stato fondato il 23 Marzo del 1919 con la costituzione dei Fasci di combattimento a Milano in piazza San Sepolcro .Tale movimento si costituì in partito col Congresso di Roma del Novembre 1921.
Alla fine del marzo 1921 i fascisti fecero il loro primo comizio a Rivoltella. Esso fu tenuto da Augusto Turati che in tal occasione espose il programma fascista. Parteciparono al comizio anche le squadre di Lonato, Desenzano e Peschiera. Il clima cominciava a farsi acceso: i primi incidenti a Rivoltella avvennero nel mese di Febbraio: dopo una tumultuosa seduta comunale sconvolta da continue grida provenienti dal pubblico, crebbe la tensione nel paese finchè nacquero tafferugli di fronte alla Trattoria della Torre con scambio di pugni e legnate. Mentre il 6 Marzo vi fu il primo scontro a Desenzano tra fascisti e socialisti durante il quale Vittorio Francoli venne ferito.
Il 1?Maggio a Rivoltella fu esposta davanti ai locali del Circolo socialista, la bandiera rossa. La reazione dei fascisti non si fece attendere e il mattino successivo essi rovistarono la sede per sequestrare la bandiera. Qualche giorno dopo il sindaco "rosso" di Rivoltella licenziò lo scrivano straordinario Baccinelli. Per vendicarsi cinque datori di lavoro fascisti licenziarono quaranta dipendenti socialisti, riassunti solo dopo che firmarono un manifesto pubblico contro l' operato del sindaco. Il 23 Agosto 1922 cadde l'Amministrazione rossa che si dimise per invito dei fascisti. Il sindaco Pezzotti tornò a riprendere la cazzuola e il badile. Circa una quarantina di fascisti di Rivoltella e dei paesi vicini festeggiarono l' avvenimento: al canto di "Giovinezza" , giunsero a tarda ora all' Osteria della Pesa.
A livello nazionale il 29 ottobre avveniva la marcia su Roma alla quale parteciparono anche squadre di Rivoltella, Desenzano, Lonato, riunitesi in un unico gruppo a Brescia.
Nel gennaio del 1923 fu istituita la Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale che riuniva e riorganizzava le squadre d'azione formalmente disciolte. Il 18 marzo dello stesso anno ebbe luogo nella piazza centrale di Desenzano la cerimonia di istituzione della Milizia Nazionale della zona chiamata centuria; sfilarono con i militi di Rivoltella Baccinelli, decorato di guerra e il sindaco del paese Giuseppe Clomer.
Nel giugno del 1924 in un fosso della campagna romana fu trovato il cadavere di Giacomo Matteotti: in tale occasione i fascisti locali giustificarono il fatto in quanto determinato da una situazione politica molto accesa.
Nel settembre del 1925 cominciò la battaglia del grano, che non riuscì comunque a fermare il fenomeno di emigrazioni interne; infatti dal 1927 molti contadini si spostarono verso i centri urbani del nord dove sorgevano molte industrie. Il fenomeno stupì in quanto la spinta era per la ruralizzazione del nostro paese, però condizionata dall'assenza di una riforma agraria.
Nel marzo del 1926 venne dal governo l'approvazione definitiva del progetto di fusione dei comuni di Desenzano e Rivoltella, realizzato in modo definitivo il 26 ottobre. Le proteste furono molte da parte dei rivoltellesi, secondo cui il paese, nettamente agricolo, si sarebbe trovato in una posizione subordinata rispetto a Desenzano, in prevalenza commerciale e turistico. La fusione dei due comuni avrebbe declassato Rivoltella a frazione con una conseguente emarginazione sociale ed economica a vantaggio del capoluogo.
La contestazione riesplose nel secondo dopoguerra, come dimostrano le partite di calcio disputate tra desenzanesi e rivoltellesi, in occasione del carnevale, per conquistare il comune.
In quell'anno era iniziata anche la campagna demografica. Vi furono concorsi per le famiglie numerose e premi per la madri più prolifiche, mentre i celibi per punizione dovettero pagare un'imposta.
Negli anni dal 1928 al 1933 fu riordinata la previdenza sociale ed ampliata con una serie di decreti. Furono istituiti l'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia e l'Ente Opere Assistenziali che si interessava anche del'organizzazione delle colonie. A Desenzano la colonia elioterapica fu istituita nell'estate del 1927.
Nel febbraio del 1929 nella chiesa parrocchiale di Rivoltella gremita di popolo si cantò il " Te Deum" di ringraziamento per la riconciliazione tra lo Stato fascista e la Chiesa. Durante la funzione, il parroco don Domenico Melegatti pronunciò un vibrante discorso.
Nel marzo di quell'anno vi furono le elezioni plebiscitarie: a Rivoltella gli iscritti alle liste elettorali erano 808, i votanti furono 766 e la lista nazionale ricevette tutti i voti.
LE DONNE E LA COLTIVAZIONE DEL BACO DA SETA
In tutte le epoche le donne di Rivoltella hanno prestato la loro opera tenace quanto silenziosa a fianco dei loro uomini. Si sono distinte per l' abnegazione con cui hanno prestato soccorso ai feriti della battaglia di San Martino, si sono sostituite agli uomini nel lavoro dei campi durante le due guerre mondiali. Preziose nell'attendere alle faccende domestiche e nell' allevare i figli, imparavano fin da bambine a svolgere innumerevoli lavori: tessere, ricamare, lavorare a maglia, per prepararsi a rispondere alle necessità della famiglia spesso numerosa.
Nel centro urbano esse dovevano integrare il magro stipendio del marito lavorando come donne di servizio per le famiglie più facoltose o nei pochi alberghi e trattorie ( l'Enrichetta, l'Alpino,l'Italia).Frequentemente prestavano la loro opera come lavandaie: era un lavoro faticoso, il bucato prima lavato in tinozze col sapone, poi, sciacquato sulla riva del lago trasportato in ceste di vimini su carriole di legno, veniva . In altri casi esse si offrivano per far da balia a bambini non loro: li allattavano e li crescevano insieme ai propri figli.
Nelle zone rurali, dopo la stagione dei raccolti, le donne si dedicavano alla spigolatura del grano del granoturco e dell'uva. Nel periodo della raccolta delle olive prendevano ad una ad una quelle che non erano entrate nel contenitore di chi sulla pianta stava effettuando tale operazione. Durante l'inverno andavano a raccogliere la legna da bruciare nelle stufe, oppure il radicchio e la cicoria, che cuocevano e poi conservavano sottaceto in vasi di vetro.
Nelle zone coltivate a vite, durante la vendemmia, si prestavano ad effettuare qualsiasi lavoro per agevolare il compito degli uomini. Non rare erano pure quelle che con la zappa alla mano , a fianco degli uomini, tra le zolle seminate a granoturco, erano impegnate a estirpare le erbe infestanti. Ma sicuramente il lavoro più impegnativo era l'allevamento del baco da seta. Va ricordato che il ricavato della vendita dei bozzoli era di esclusiva pertinenza della padrona di casa.
Date le condizioni domestiche in cui le larve dei bachi dovevano crescere e sviluppare, il primo compito era quello di mantenere costante la temperatura dell'ambiente e quindi il camino doveva essere fornito di legna senza interruzione. In secondo luogo tali larve dovevano essere nutrite con le foglie del gelso asciutte e fresche: esse erano sminuzzate prima di essere date loro in pasto.
Notevole a Rivoltella era il commercio dei bozzoli, del resto, prima della guerra l' allevamento del baco da seta era ancora fiorente nella zona collinare del basso Garda.
In ogni cascinale vi era una stanza o più destinate all'allevamento dei "caaler".Così erano chiamati i bachi perché dopo l'immobilità e la pigrizia del periodo larvale, si agitavano, si mettevano in movimento, alzando la testa come piccoli e vivaci puledri, nel tentativo di arrampicarsi sul sostegno per iniziare a formare il bozzolo. Era questo il periodo cui i contadini ponevano sulla stuoia di canna o di vimini, fascetti di erica o di altri ramoscelli secchi, opportunamente disposti che si dicevano "boschi".
Questi animaletti dai bacolini scuri, con lunghi peli, si sviluppavano a tappe successive, separate l'una dall'altra da una muta detta "dormita"o "età", fino a diventare larve di nove centimetri che si avvolgevano in una celletta dorata dalle trame sempre più fitte sino a che si chiudevano completamente nel bozzolo.
Il momento più delicato era quando l'involucro si schiudeva perché da esso dopo tre settimane, sarebbe uscita una bianca farfalla.
Allora i bozzoli dovevano essere riuniti in una stanza dove con una stufa si raggiungeva una determinata temperatura così che si arrestasse il processo di trasformazione della larva in crisalide essicandola.
Per noi ragazzi la stagione dei bachi significava alzarsi all'alba per raccogliere provviste di foglie per i bachi che arrivavano al periodo chiamato dai contadini della "gran mangiata".
I proprietari di campagna e i commercianti facevano dei guadagni, se la raccolta era stata buona, non contaminata da malattie. Nel 1757 infatti una grave malattia detta "sferza" colpì i gelsi della regione e compromise l'allevamento dei bachi da seta. Nel 1853 poi anche sul Garda si diffuse l'atrofia dei bachi da seta. Nel 1901 a Manerba e a Gardone Riviera compare la diaspis pentagona, la malattia dei gelsi che compromise l'allevamento dei bachi da seta che si dovette interrompere per un po' di tempo.
Sui quotidiani provinciali, nel mese di Maggio e di Giugno si potevano leggere, alla fine dell'elenco dei prezzi del mercato di Desenzano , notizie come queste <>. <>. La foglia dei gelsi, quando si sviluppava in abbondanza, veniva anche esportata.
A Desenzano, più tardi altrove, c'erano stati, fino al 1914 alcuni filatoi che chiusero per crisi generale che colpì la sericoltura, crisi dovuta alla forte concorrenza giapponese .La gente li chiamava così, ma in realtà erano ampi locali dove venivano effettuati l'ammasso e la cernita dei bozzoli che potevano essere macchiati, mal riusciti o già forati dalla crisalide. In Capolaterra esiste ancora oggi come ricordo della vecchia attività, il vicolo Filatoio.
Fra i più importanti commercianti di bozzoli c'era Felice Anelli, nipote del poeta Angelo Anelli che aveva cantine e filatoio in piazza XX Settembre ( ora piazza Matteotti) e nell'attuale via Carducci. Il vasto fabbricato, che serviva come filatoio, ceduto al Credito Agrario Bresciano; nel 1925, fu acquistato dal Municipio e con un cavalcavia fu congiunto alla parte vecchia del convitto Civico. Felice Anelli era stato proprietario della filanda di Calcinato fino al 1911 che poi venne liquidata. Tra gli altri proprietari di filatoi ricordiamo Ferdinando Polver che aveva cantine e filatoio in via Nazario Sauro all'incrocio con via Santa Maria. Era qui che i rivoltellesi portavano i bozzoli che, dopo una accurata selezione, venivano spediti alle filande della provincia fra cui quella dei Salaorni a Lonato.
IL GIORNALE DI DESENZANO
Anche Desenzano aveva il suo giornale, veniva chiamato "El giurnal de Desensà", che, tradotto in italiano, significa
"Il giornale di Desenzano" .
Era stampato nella tipografia di Ferruccio Ghidini, e ne venivano pubblicate al massimo 40 o 50, copie, anche perché a volte la carta scarseggiava.
Le notizie erano poche e riguardavano soprattutto gli aerei, perché vi era l'Idroscalo proprio vicino a Rivoltella.
Il giornale veniva stampato nel seguente modo: prima venivano incise le lastre di piombo con i caratteri di stampa degli articoli e le fotografie, poi si utilizzava una macchina chiamata pigiatrice formata da due tavole, una sottostante all'altra. Sulla parte inferiore si adagiava il foglio di carta, su di esso venivano adagiate le lastre di piombo, precedentemente inchiodate su uno spessore di legno e bagnate di inchiostro. Sul foglio, pressato fra le due tavole, rimanevano così impressi gli articoli e le fotografie. Pagina dopo pagina il giornale prendeva vita.
Allora il giornale non veniva venduto nelle edicole, ma distribuito dal figlio del tipografo direttamente alla gente del posto.
Il giornale costava 2 lire per chi voleva acquistarlo, ma lo si poteva anche "affittare" alla modica spesa di mezza lira.
Lo si trovava di frequente anche in tutte le osterie di Rivoltella, dove gli uomini si incontravano la sera e nei giorni festivi.
Fondato intorno agli anni trenta, usciva con una frequenza di non più di due pubblicazioni settimanali, sia per la difficoltà di raccogliere notizie, sia per la scarsità della carta.
Nel 1940, però, l'attività giornalistica cessò per la morte del proprietario della tipografia: gli eredi non avevano alcun interesse a proseguire nella divulgazione del giornale.
LA II GUERRA MONDIALE
Ricordo ancora quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale e anche Rivoltella scese sul campo di battaglia. Io allora avevo 15 anni, già da tempo lavoravo in campagna con mio padre.
Il 10 giugno 1940 era una giornata limpida come poche se ne erano viste. Nel tardo pomeriggio mi trovavo in piazza del Municipio con i miei amici.
Dall'altoparlante, fissato sul poggiolo del comune, si udì la voce del duce, alta, piena di pause, insistita su alcune vocali prolungate: << Combattenti di terra, di mare, di aria! Camice nere della rivoluzione e delle legioni! Uomini e donne d'Italia, dell'Impero e del Regno di Albania! Ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte nel cielo della nostra Patria: l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Scendiamo campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente (...)>>.
In paese si respirava una aria strana di tensione. La gente girava per le strade ammutolita.
Decine di giovani ragazzi, alcuni dei quali appena diciottenni, partirono per i fronti albanese, russo e francese nei giorni successivi.
In quel periodo il paese rimase deserto: non si vedevano in giro i giovani, solo qualche bambino, gli anziani e le donne che, per provvedere alla famiglia, dovevano lavorare anche al posto dei propri mariti, richiamati alle armi.
Una delle attività ancora funzionante durante la guerra, era il mulino dei Mura.
Anche i Francoli dovettero chiudere la loro falegnameria per la mancanza di operai.
Il 10 gennaio 1940 iniziò la distribuzione della carta annonaria individuale, chiamata comunemente tessera del pane; in questo periodo il cibo scarseggiava e si diffuse il "mercato nero". Questa tessera permetteva l'acquisto del pane e di tutti i generi alimentari di prima necessità.
Ricordo ancora con commozione i primi bombardamenti contro Rivoltella e i territori qui vicini.
Bombardarono anche il viadotto di Desenzano, lo stabilimento dei Francoli e la casa adiacente allo stabilimento, un mendicante che vi aveva trovato riparo per la notte, rimase ucciso.
Il "pippo", come veniva chiamato l'aereo notturno, bombardava alla sola vista di una qualsiasi luce, e alcune bombe caddero anche vicino anche la Villa Brunati, l'allora residenza delle truppe tedesche. I tedeschi erano arrivati dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943 ed erano numerosi anche perché eravamo proprio nel territorio della Repubblica di Salò. Alla Tassinara erano ospitati gli alti gerarchi fascisti tra cui il generale Graziani. Il periodo peggiore l'abbiamo però vissuto durante la ritirata: i soldati tedeschi rubavano dalle case, requisivano biciclette e abiti civili per scappare, minacciavano donne, bambini ed anziani.
La situazione di Rivoltella cominciò a migliorare con l'arrivo degli americani, che organizzarono feste, risollevando così l'umore di tutta la popolazione, distribuirono cioccolata gratuitamente e burro, alimenti che allora non si trovavano con facilità sul mercato.
Finita la guerra i giovani soldati sopravvissuti cominciarono a tornare a casa. Ciascuno raccontava la propria esperienza e noi, più giovani, ascoltavamo con profonda commozione quelle avventure tanto difficili da sembrarci inverosimili.
Il mio amico Sterza Carlo raccontava:
<>
Anche Miglioranzi Luigi non perdeva mai l'occasione per rievocare gli anni passati in guerra:<>.
Anche Mussi Guglielmo, trasferitosi a Rivoltella dopo la guerra, raccontava la sua esperienza : <>.
Giuseppe ci raccontava dei sei lunghi anni trascorsi in guerra.
<>.
Anche i morti della seconda guerra mondiale sono ricordati sui monumenti di Piazza degli Alpini.
LA DIFFICILE RIPRESA
Nell'immediato dopoguerra la popolazione visse un periodo di estrema povertà: le donne lavoravano ancora nei campi, i laboratori artigianali stentavano a riprendere la loro attività, il paese non aveva subito grandi distruzioni a seguito della guerra ma necessitava comunque di un intervento di rinnovamento urbanistico.
Alcune famiglie, trovandosi in gravi difficoltà economiche, decisero di emigrare verso altri paesi in cerca di fortuna. Le mete privilegiate erano l'Argentina, il Venezuela e l'Australia.
Amelia Dusi nel suo libro "Premiata fabbrica di liquori Mario Chesi" così descrive il periodo:<< Lo scenario delle cose e gli animi delle persone apparivano ben più profondamente feriti e segnati. Era impossibile per uomini e cose tornare alle condizioni di prima.
Nel 1946 il costo della vita risulta cresciuto 25 volte rispetto al 1938, mentre gli stipendi 13 volte e i salari 15. Per avere 1000 lire occorreva lavorare 25 ore in fonderia: il pane con la tessera costava lire 25 al chilo, la pasta 42, la carne 300, lo zucchero 270, il vino 70>>.
Molti lavori artigianali scomparvero, fra questi i ramai, i maniscalchi, i parolotti, i tintori, i fabbricanti di carrozze, di selle, di fruste.
Purtroppo lo sviluppo delle tecnologie aveva portato ad affrettare la fine di mestieri e di imprese un tempo floride, ora inadeguate ai tempi.
<< Un processo analogo stava accadendo per le distillerie... Nella zona del Garda risultano 3, salgono a 5 nel 1961, 4 si estinguono nel decennio successivo, nel 1971 ne risulta una sola>>. Anche la distilleria Francoli cessa perciò l'attività.
Si punta ormai sullo sviluppo del turismo.
I centri storici di Desenzano e Rivoltella si sono riempiti di pizzerie, gelaterie, boutique e negozi di souvenir.
Altro fattore importante di Desenzano e Rivoltella negli anni Sessanta fu l'intensificazione dell'attività edilizia legata al turismo, si adottò infatti una politica urbanistica destina perlopiù alle "seconde case" o all'abitazione intesa come "bene rifugio". A quel tempo, infatti risultò da un censimento che delle 11.049 abitazioni solamente 8.143 erano occupate dai 21.000 Desenzanesi.
L'ottocentesco ponte ferroviario, con arcate ogivali, fu sostituito con un ponte a pilastri e travature, uno dei primi edificati con questo stile negli anni della ricostruzione.
A Rivoltella fu costruita la minitangenziale a lago, liberando il paese dal traffico della strada statale che passava proprio all'interno. Pochi anni dopo venne ampliata la spiaggia vicina al porto per offrire uno spazio balneare ai turisti che sceglievano di soggiornare in questo piccolo centro.